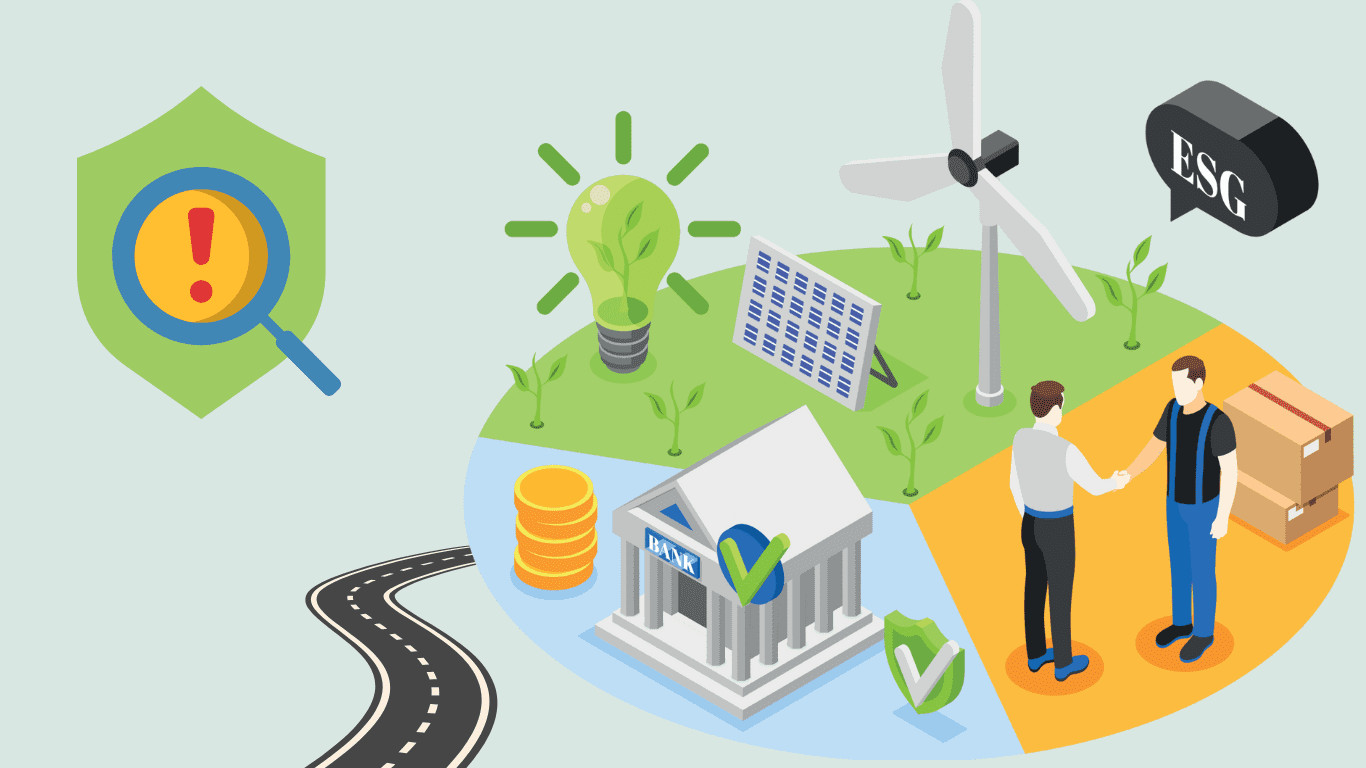Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La proposta si prefigge di favorire l’adozione di comportamenti sostenibili e responsabili nelle supply chain e nelle aziende di tutto il mondo.
Il ruolo delle aziende sarà fondamentale, poiché saranno chiamate a individuare eventuali prassi contrarie all’etica nelle proprie attività, come il lavoro minorile o lo sfruttamento dei lavoratori e porvi rimedio. In questo post sul blog daremo risposta alle domande frequenti su cosa comporta concretamente questa proposta e sulle sue possibili implicazioni per le aziende, in vista dell’entrata in vigore il prossimo anno.
1 – Cosa prevede la proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità?
I fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) stanno acquisendo un’importanza fondamentale per le aziende e i governi di tutto il mondo. In ogni angolo del pianeta, sono sempre più serrati i controlli sull’origine delle merci nell’ambito delle supply chain: non ci si limita più a considerare quello che viene prodotto, ma anche come è stato prodotto. Sotto la spinta di azionisti, governi, gruppi di pressione e dell’opinione pubblica, sono venute alla ribalta prassi sospette e le storture di mercati ristretti per materie prime cruciali. Si moltiplicano i casi di aziende prese di mira per il loro ambientalismo di facciata, che recentemente hanno coinvolto aziende come H&M, KLM e Ryanair. Dichiarazioni esagerate o fuorvianti sulle credenziali di un’azienda per quanto riguarda i fattori ESG comportano rischi notevoli. È sempre più lungo l’elenco delle aziende citate in giudizio per il cosiddetto “greenwashing”, termine in cui rientrano dichiarazioni vaghe, inesatte, obsolete, infondate o false sulle attività o i prodotti di un’azienda. A nostro avviso, questa tendenza è destinata ad aumentare sempre più rapidamente.
La più importante novità in questo settore in rapida evoluzione è la proposta di direttiva della Commissione europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (“la Direttiva”), pubblicata il 23 febbraio 2022. Nonostante sia passibile di modifiche prima dell’entrata in vigore, per le organizzazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione apre la strada a importanti cambiamenti nel campo dei diritti umani e della “due diligence” ambientale per le supply chain di tutto il mondo.
La Direttiva ha un vasto raggio d’azione e avrà ricadute su tre diverse categorie di aziende. Nello specifico, l’articolazione delineata dalla Commissione è la seguente. Gruppo 1: grandi società a responsabilità limitata europee. Si tratta, secondo le stime della Commissione europea, di circa 9.400 aziende. Per rientrare nel Gruppo 1, l’azienda deve avere sede nell’Unione europea, contare più di 500 dipendenti e generare un fatturato netto superiore ai 150 milioni di euro a livello globale. La seconda categoria (Gruppo 2) comprende circa 3.400 aziende operanti nei cosiddetti settori “ad alto impatto”. Le aziende del Gruppo 2 devono avere più di 250 dipendenti e un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro a livello globale. Inoltre, tali aziende devono operare nei cosiddetti “settori ad alto impatto”: come da spiegazione fornita dalla Commissione europea, vi rientrano settori quali “fabbricazione di tessuti; agricoltura; estrazione di risorse minerarie”. Dato che si tratta di aziende per loro natura ad alto rischio, la proposta prevede che le norme “inizieranno ad applicarsi a decorrere da due anni dopo l’entrata in vigore per il Gruppo 1”. Nel terzo gruppo rientrano le imprese di paesi terzi operanti nell’UE con un fatturato generato nell’Unione europea in linea con le soglie sopra menzionate. Sono escluse le piccole e medie imprese (PMI), che tuttavia potranno essere “indirettamente interessate” da alcune delle disposizioni della Direttiva.
La proposta di Direttiva è probabilmente la novità più discussa, ma in realtà anche altri paesi stanno adottando misure che vanno nella stessa direzione, data la centralità sempre maggiore delle tematiche ESG. Negli Stati Uniti, per esempio, la commissione investimenti della Securities and Exchange Commission (SEC) sta avanzando proposte per stabilire un quadro di riferimento per le dichiarazioni in ambito ESG, con possibili conseguenze di vasta portata per le aziende operanti sul territorio nordamericano. In altri paesi, come la Francia, i codici di condotta in ambito ESG su base volontaria sono stati accolti con molto favore dalle aziende.
2 – Quali sono le differenze rispetto alla legge per contrastare le forme moderne di schiavitù nel Regno Unito (Modern Slavery Act)?
Il Modern Slavery Act entrato in vigore nel Regno Unito è considerato lo standard di riferimento nella protezione dalle minacce e dalle violazioni più gravi dei diritti umani. La Direttiva, però, si spinge oltre, con un ulteriore giro di vite rispetto al suo equivalente britannico e con un campo di applicazione potenzialmente globale. Passerà al vaglio tutti i livelli della supply chain, dalle materie prime ai rivenditori finali. Inoltre, introduce meccanismi di riparazione tra cui la supervisione, sanzioni economiche, scuse formali, risarcimenti danni e l’intimazione a modificare le prassi adottate. A differenza del Modern Slavery Act, si applicherà a tutte le aziende attive e generanti reddito nell’Unione europea.
3 – Su quali standard o requisiti si fonda la legislazione?
La Direttiva si fonda in parte su uno studio del 2020 eseguito dal British Institute of International and Comparative Law su incarico dell’Unione europea. Nonostante si ispiri, tra l’altro, ai Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, non sono mancate le critiche da parte di quanti ritengono che la Direttiva non faccia abbastanza: soprattutto per quanto riguarda il mancato superamento degli standard già previsti dai Principi Guida dell’ONU in diversi ambiti e la mancata applicazione all’intera supply chain (dato che sono escluse le PMI).
4 – Cosa devono fare le aziende per dimostrare di agire in modo conforme?
La Commissione precisa che le aziende interessate dovranno rispettare una serie di nuovi obblighi, tra cui:
- l’integrazione del dovere di diligenza tra le politiche aziendali
- la pubblicazione di dichiarazioni circa le procedure di “due diligence” adottate
- il monitoraggio proattivo (per esempio, attraverso un piano d’azione) per individuare impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente ascrivibili alla propria azienda, e l’impegno a porvi rimedio
- l’adozione di misure atte a prevenire gli impatti negativi dovuti a tali attività commerciali
- il dovere di porre in essere procedure per la gestione di reclami in materia di diritti umani/ESG
Inoltre, il cambiamento comporterà costi e sarà assolutamente necessario assicurare che le modifiche apportate vadano nella direzione auspicata fin da subito.
5 – Le modifiche normative sembrano essere relative all’Unione europea o a nazioni specifiche; riguarderanno anche le aziende britanniche?
Sì. La Direttiva si applicherà alle aziende che vendono all’Unione europea, non solo a quelle con sede negli Stati membri.
Il terzo gruppo di aziende include le imprese operanti nell’UE e con un fatturato superiore ai 150 milioni di euro nell’Unione europea o tra i 40 e i 150 milioni di euro nell’Unione europea, a condizione che almeno la metà di tale reddito provenga da settori “ad alto impatto”. Pertanto, una vasta schiera di aziende britanniche sarà interessata dalla Direttiva e dovrà conformarvisi per non incorrere nelle sanzioni previste. Nonostante il Regno Unito, dopo la Brexit, non sia tenuto a uniformarsi alla lettera alle normative europee, è probabile che un regime in qualche misura analogo venga introdotto anche oltremanica per consentire alle multinazionali britanniche di operare a pieno titolo nell’Unione europea.
Il Regno Unito potrebbe dover introdurre un’autorità di vigilanza analogamente agli altri Stati membri. Un mancato allineamento con l’Unione europea potrebbe determinare un’implementazione a macchia di leopardo e le aziende britanniche potrebbero finire col violare le norme in uno Stato membro ma non in un altro, a seconda di come la legislazione verrà recepita nei vari paesi. In quest’ottica, i fattori ESG non conoscono confini: si tratta dunque di un ottimo esempio di come il Regno Unito continui a rientrare nella sfera della legislazione e della governance europee.
Una supply chain etica è una supply chain sostenibile
La tua azienda è tenuta a operare in modo sicuro, responsabile e sostenibile. La creazione di una supply chain trasparente e collaborativa, impegnata a migliorare di continuo le procedure di “due diligence”, rappresenta il primo passo che le aziende dovrebbero compiere da subito per evitare future sanzioni e rischi per la reputazione. Il nostro Ethical Business Programme aiuta le aziende ad accertarsi che tutte le parti coinvolte operino nel rispetto del diritto internazionale, adottino le migliori prassi in ambito ESG e che tutti possano vivere e lavorare in modo coerente con i propri valori. Chiedi di farti ricontattare per saperne di più.
L’elenco di domande frequenti è stato redatto da David Hansom, Partner e Head of Procurement Law presso lo studio Clyde & Co, specializzato in questioni relative alla gestione della supply chain globale e al procurement.